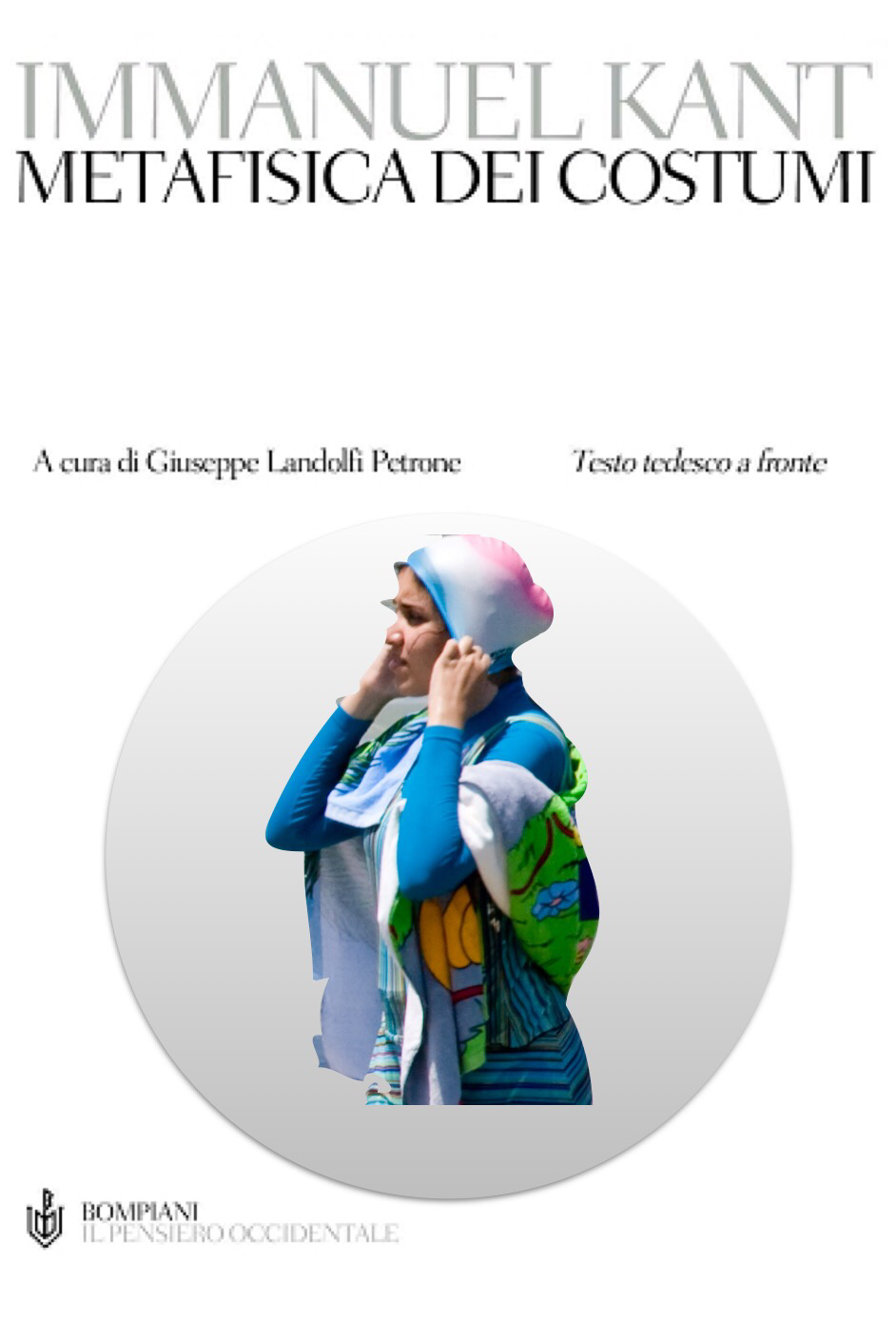Un lungo articolo nel quale, partendo dagli scritti di Hans Kelsen, ragiono sull’origine comune delle norme sociali e delle leggi di natura e sul dualismo tra società e natura.
Premessa
Capita di scrivere di Antigone e, immersi in un contesto di norme giuridiche e morali, neanche ci si rende conto dell’ambiguità dell’espressione “legge naturale” che può indicare – come era il caso per Antigone – sia leggi che sono valide e giuste per natura (come la cosiddetta “regola aurea” del non fare agli altri quel che non vorresti venisse fatto a te) sia leggi che riguardano i fenomeni naturali (come “la velocità di caduta di un corpo non dipende dalla sua massa”).
Così il titolo “Le leggi naturali sono in realtà molto umane” è stato frainteso e l’equivoco si è concluso con un invito, da parte di Choam Goldberg, a riflettere se anche le leggi naturali – nel secondo significato, quello scientifico – possono essere costrutti sociali.
Società e natura: una ricerca sociologica
La stesura di questo articolo si è intersecata con la notizia della morte del filosofo e sociologo Bruno Latour che sosteneva proprio questo: la scienza è una costruzione sociale (ovviamente in una forma più raffinata di questo semplice riassunto). Ma non pensavo di scrivere di Latour, bensì del filosofo e giurista Hans Kelsen. E questo perché volevo approcciare il tema da un altro punto di vista: non tanto capire se le leggi di natura siano socialmente costruite ma da dove nasce l’idea di una legge di natura.
Ora, Hans Kelsen è il padre della dottrina pura del diritto, dove quel “pura” significa studiare il diritto lasciando perdere cose come l’etica, la politica, la storia, la sociologia e ragionare su cosa è, in generale, una norma giuridica. Il che comunque non significa etica, politica, storia o sociologia siano perdite di tempo. Infatti nel 1943 – dopo aver lasciato l’Europa per sfuggire al nazismo; per i dettagli consiglio caldamente di recuperare i suoi Scritti autobiografici (Diabasis 2008) – pubblicò un libro che di sottotitolo ha proprio Ricerca sociologica. Il titolo è invece Società e natura ed è un’opera che alcuni studiosi non sanno bene come inquadrare, all’interno del pensiero di Kelsen, e viene spesso ignorata, per quanto la tesi di fondo del libro trovi spazio anche nelle opere successive. È ad esempio riassunta nell’articolo Causalità e imputazione del 1950, pubblicato in appendice ai Lineamenti di dottrina pure del diritto. La traduzione italiana di Società e natura, fatta da Laura Fuá, temo sia esaurita; io ho una copia dell’edizione del 1992 pubblicata da Bollati Boringhieri.
Oggi è una lettura un po’ imbarazzante, per come descrive – peraltro senza indagini sul campo ma basandosi su resoconti – dei “popoli primitivi” caratterizzati fondamentalmente da uno scarso sviluppo mentale. Vero che siamo negli anni Quaranta (e le idee fondamentali del libro risalgono ad almeno un decennio prima, stando alla prefazione di Renato Treves), ben prima che studiosi come Claude Lévi-Strauss ci mostrassero la razionalità dei “selvaggi”, ma il punto non è accusare o assolvere Kelsen dall’accusa di occidentalismo, bensì chiederci se vale la pena, oggi, leggere un testo dall’impostazione così datata. La risposta è sì, ne vale la pena perché il ragionamento di Kelsen, al di là dei pregiudizi sui “popoli primitivi”, riguarda il dualismo tra società e natura.
Questo dualismo, nella forma dell’opposizione tra “essere” (natura) e “dover essere” (società) è uno degli elementi alla base della dottrina pura del diritto. Kelsen la presenta proprio con la differenza da cui siamo partiti, quella tra “le leggi naturali [che] sono proposizioni sul corso effettivo degli eventi” e “le regole giuridiche [che] sono prescrizioni per il comportamento degli uomini” (la citazione è da Teoria generale del diritto e dello Stato, ma il concetto lo si trova anche in altri testi). È bene precisare che il “dover essere” non caratterizza la società in generale ma solo quelle scienze normative – come la morale, il diritto e, almeno secondo Kelsen, anche la teologia – che non descrivono quello che le persone fanno, e che rientra nella dimensione dell’essere, ma quello che le persone dovrebbero fare: “non uccidere” non significa che le persone non uccidano, ma che non dovrebbero farlo (morale) o che quando lo fanno dovrebbero essere punite (diritto).
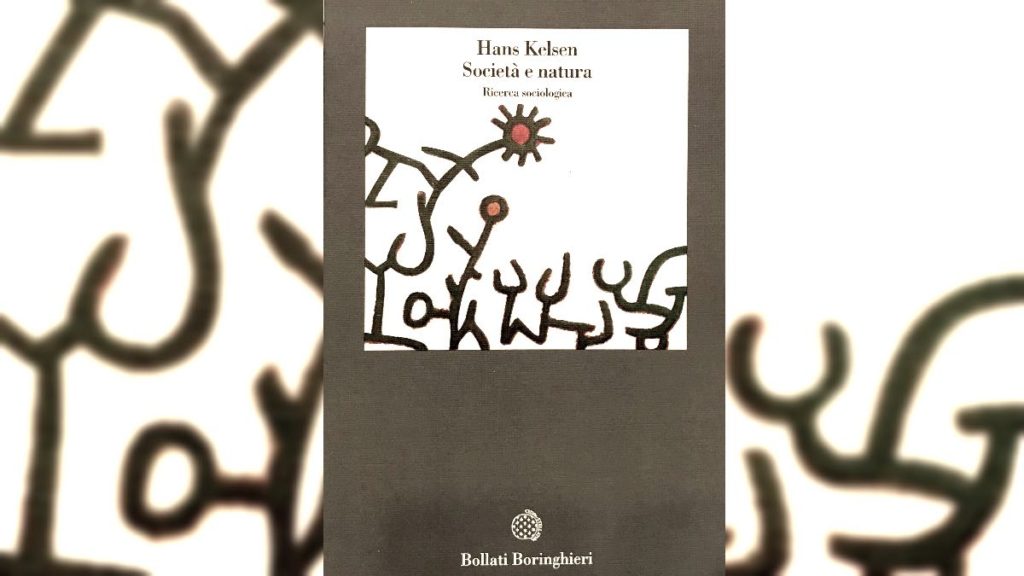
Le origini del dualismo tra natura e società
Da dove arriva questo dualismo tra natura e società, tra essere e dover essere?
“La differenza fra essere e dover essere non può essere ulteriormente spiegata: è un dato immediato della nostra coscienza” si legge nella Dottrina pura del diritto, ma questo non impedisce di indagare la genesi di questo concetto. Norme sociali e leggi di natura hanno infatti un’origine comune che Kelsen identifica nel principio del contrappasso (mantengo la traduzione usata in Società e natura, anche in omaggio agli studi di Kelsen sul pensiero politico di Dante, per quanto credo che oggi sarebbe più opportuno parlare di retribuzione).
Il contrappasso è la lex talionis, la legge del taglione, quella che vede una corrispondenza tra azione (illecita) e punizione, come se la seconda dovesse ristabilire un equilibrio rotto dalla prima. Il contrappasso non è la semplice reazione a una minaccia dovuta all’istinto di autoconservazione e neanche il pretendere di tornare alla situazione di partenza tramite una qualche riparazione del danno: è l’infliggere al colpevole un danno paragonabile a quello che lui ha inflitto a noi, fondamentalmente una vendetta regolata.
Per i “primitivi”, scrive Kelsen, il principio del contrappasso regola tutto, senza distinzioni tra realtà naturale e realtà sociale. Ogni evento si spiega in quanto ricompensa o punizione di un altro evento e non c’è punizione senza colpa o ricompensa senza merito. Non so se davvero non vi fosse alcuna differenza tra una frana e il vicino che ti tira una bastonata, ma l’idea di base mi sembra compatibile con gli studi sul pensiero magico e la psicologia popolare (quella che intuitivamente ci fa attribuire stati mentali alle altre persone e talvolta anche a oggetti). Cosa, che ovviamente non riguardano solo i “popoli primitivi” ma l’umanità in generale.
I primi filosofi e i primi sovrani
Poi nel mondo greco arrivarono i primi filosofi, non a caso oggi conosciuti come “naturalisti” perché appunto cercarono una spiegazione unitaria dei fenomeni naturali, qualcosa che andava quindi al di là del singolo evento. Ma – e questa è un aspetto molto interessante – tutto questo non accadde perché si stava capendo che le cose si comportano diversamente dalle persone. Per i primi naturalisti, scrive Kelsen, il carattere normativo della spiegazione era lo stesso di prima, la realtà sociale continuava a essere il modello dal quale partire per comprendere tutta la realtà:
Le piú antiche scuole filosofiche greche, a simiglianza del pensiero mitico dell’uomo primitivo, spiegarono la natura in base all’analogia con la società.
Che cosa era cambiato quindi tra il pensiero mitico e quello filosofico? A essere cambiata era la società, con un sovrano che accentrava il potere inclusa la giustizia, regolando il gioco di ricompense e vendette con delle norme generali.
La comunità che detiene il comando, lo Stato, offre il modello di quell’ordine che la filosofia trasferirà nell’universo.
Il singolo evento non viene ricondotto a un precedente evento del quale sarebbe la reazione (di ricompensa o di punizione), ma a una legge generale. È a questo punto, in cui abbiamo leggi e non più singoli contrappassi, che è possibile separare le leggi degli uomini da quelle di natura:
L’idea di una legge universale della natura, che in principio era semplice proiezione della legge dello Stato nel cosmo, si emancipa dal suo prototipo e acquista un significato del tutto indipendente. La legge dello Stato, o norma, da un canto, e la legge della natura, o legge di causalità, dall’altro, diventano due principi completamente diversi.
Si tratta ovviamente di un processo lento: il carattere normativo delle leggi di natura rimane determinante ancora per qualche secolo. Kelsen indica nell’atomismo di Leucippo e Democrito la nascita di un principio causale che non sia espressione di una volontà più o meno personale. Parliamo del passaggio da una legge naturale inviolabile perché “non è assolutamente possibile evitare la reazione a una eventuale disobbedienza” a una legge che diventa “l’espressione di una necessità obbiettiva impersonale”.
Una trasformazione simile avviene anche in ambito sociale. Qui il grande innovatore è Protagora che propose un’idea che ancora adesso si fatica ad accettare: non puniamo per ristabilire un equilibrio che il colpevole ha infranto, la pena non è retribuzione ma prevenzione:
La punizione non è inflitta per motivi misteriosi, bensì per scopi assai chiari. Nessuno punisce pel fatto e pel motivo della colpa, salvo chi lo fa irragionevolmente a sfogo di vendetta, come le bestie. Chi punisce ragionevolmente non punisce per il fatto passato – ciò che è avvenuto non si può fare che non sia avvenuto – ma per l’avvenire, affinché non pecchi piú né il colpevole né altri che lo veda punito. Con questo pensiero ammette che la virtú si possa insegnare; egli punisce per prevenire.
La scienza moderna e le sue cause
Possiamo concludere con Leucippo e Democrito la storia della separazione tra natura e società? Verrebbe da rispondere di sì: con la scienza moderna si capisce come studiare meglio la natura, ma l’idea di base resta quella di una causalità non determinata da una qualche forma di volontà.
Eppure Kelsen vede ancora un’ombra della vecchia concezione, un residuo del contrappasso: il concetto di causalità. In natura, osserva Kelsen, non esistono cause ed effetti ma quelle che lui chiama “dipendenze funzionali“, come quella che lega temperatura e pressione di un gas. Pensare che l’aumento di temperatura sia la causa dell’aumento della pressione significa applicare alla natura i concetti di colpa e punizione.
Il primo a intuirlo fu Hume, attribuendo l’impressione che un fenomeno ne causi un altro all’abitudine dell’osservatore (e Kelsen ipotizza di nuovo un’analogia con le leggi umane, in particolare il diritto consuetudinario). Poi arrivarono Kant, Ernst Mach e Werner Heisenberg ma il concetto di base è che non c’è una cosa che possa essere definita “causa” e una cosa “effetto” – a meno che non ci mettiamo di mezzo la volontà umana che desidera aumentare la pressione e quindi scalda il gas o, al contrario, desidera scaldare un gas e allora lo comprime.
Quando la causalità si emancipa dal contrappasso, e la legge di natura dalla norma sociale, la natura e la società appaiono come due sistemi completamente diversi. È possibile immaginare un sistema di norme che regolino la condotta umana e organizzino la società in un ordine completamente diverso dalle leggi della natura, senza ricorrere alla finzione del libero arbitrio e senza contraddire quindi al principio di causalità.