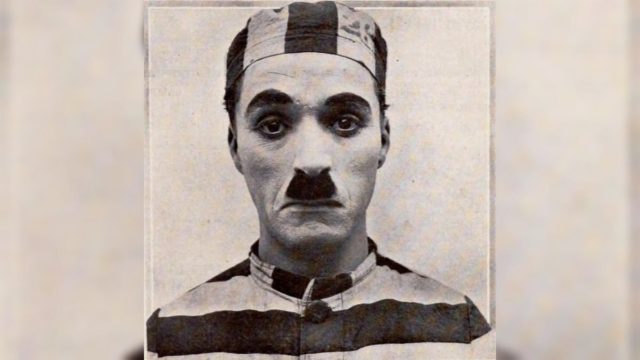Raccontare la storia di un meteorite che colpisce la Terra non è un’idea particolarmente originale. Poi certo, più che l’originalità dell’idea conta come la si sviluppa ed è su questo punto che si gioca la differenza tra due film incredibilmente vicini nella premessa e incredibilmente lontani nella realizzazione. L’uscita quasi contemporanea (almeno negli Stati Uniti) di Deep Impact e di Armageddon ha legato i due film. Nel 1998 era impossibile parlare dell’uno senza citare l’altro; poi Deep Impact è lentamente scivolato nell’oblio (o almeno così mi pare), mentre Armageddon è diventato a suo modo un classico.
Perché mi era piaciuto di più Deep Impact
In entrambi i film si scopre che un asteroide/cometa colpirà la Terra. Per evitare la scomparsa dell’umanità si cerca di deviare o distruggere il corpo celeste tramite delle bombe atomiche che però non possono essere semplicemente lanciate. La missione per far esplodere l’asteroide/cometa ovviamente incontra diversi problemi e alla fine sarà necessario un sacrificio.
Questo quel che i due film hanno in comune. Ma Deep Impact racconta quello che accade sulla Terra, come l’umanità (o meglio quella parte di umanità che vive negli Stati Uniti) si prepara a livello personale e collettivo alla catastrofe. Armageddon invece racconta l’improbabile e scanzonata impresa di distruggere l’asteroide.
Credo di essere stato uno dei pochi a preferire Deep Impact ad Armageddon.
Perché? Un po’ per la maggiore plausibilità scientifica: gli eventi raccontati in Deep Impact sono plausibili e del resto sono stati coinvolti diversi consulenti e tra le fonti di ispirazione troviamo un romanzo di Arthur C. Clarke. Di plausibile, in Armageddon, c’è invece davvero poco, dalla dimensione dell’asteroide alla tecnologia usata per deviarlo. Alcune “licenze poetiche” sono funzionali alla trama. Ad esempio lo scarso preavviso con cui viene trovato l’asteroide serve a giustificare il fatto di non avere il tempo per addestrare degli astronauti. Ma in generale denotano un sostanziale menefreghismo per la realtà.
Ma a convincermi di più di Deep Impact era il fatto di voler raccontare l’umanità, non un grosso sasso che esplode all’ultimo secondo per evitare l’impatto.
Perché mi piace di più Armageddon
Questo, appunto, nel 1998. Recentemente ho rivisto entrambi i film e ho cambiato idea.
Certo, Armageddon resta un’improbabile e scanzonata avventura, ma lo fa senza prendersi sul serio. Anzi. Lo mostra un piccolo aneddoto: l’attore Ben Affleck aveva chiesto al regista Michael Bay come mai era più semplice addestrare Nella traccia di commento, Ben Affleck dice di aver chiesto al regista Michael Bay come mai fosse più facile addestrare dei trivellatori a diventare astronauti invece che addestrare degli astronauti a diventare trivellatori, ottenendo un “shut the fuck up” come risposta.
Deep Impact invece si prende molto sul serio. E oggi trovo le riflessioni etiche e psicologiche del film superficiali e approssimative, con questa retorica della speranza e del sacrificio. Alla fine , per quanto caricaturali, risultano più convincenti le reazioni psicologiche dei personaggi di Armageddon. Certo, decidere chi salvare e chi no è un problema di giustizia tutt’altro che banale e la soluzione prospettata è interessante: una prima tornata in base all’utilità e poi un semplice sorteggio. Ma alla fine la cosa rimane lì, senza troppa voglia di approfondire o di ragionare su possibili alternative.
Così mentre Armageddon entrava nell’immaginario collettivo e diventava un film con cui confrontarsi, Deep Impact scompariva senza lasciare grandi tracce. E secondo me il problema è appunto quello: un film riusciva a mantenere quanto promesso, l’altro no.
Cosìlla fine ha vinto Armageddon. E lo vediamo nel più recente Don’t Look Up: anche qui abbiamo una cometa che minaccia la Terra, anche qui abbiamo l’ambizione di raccontare come l’umanità affronta una crisi, con riferimenti al riscaldamento globale e alla pandemia. Ma il film, per stile e narrazione, è più vicino ad Armageddon che a Deep Impact.